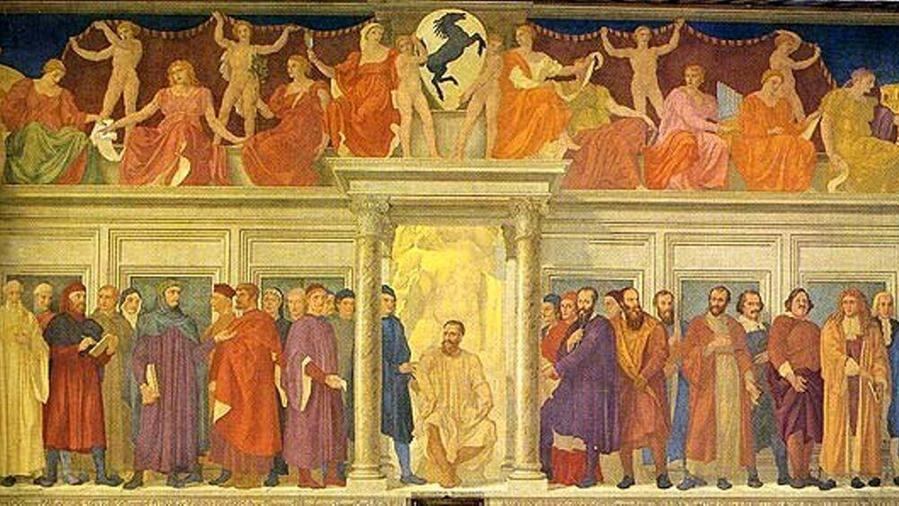
Ci sono personaggi il cui nome proprio è divenuto tanto famoso da trasformarsi in un nome comune. Può apparire un fatto curioso, eppure è accaduto. Si pensi, per esempio, al caso del nostro celeberrimo concittadino Mecenate: oggi, come è noto, per identificare una persona che protegge gli artisti o che, comunque, incoraggia e sostiene anche economicamente le attività culturali si usa il sostantivo “mecenate”.
Ma chi fu in realtà questo antico romano nato fra il 70 e il 74 a. C. e morto l’ 8 a. C.? Un uomo ricchissimo? Certamente, tanto da lasciare in eredità all’imperatore Augusto una vera e propria fortuna, che a lui veniva dalla sua opulenta famiglia di origine etrusca. Un abile politico? Senza dubbio: non poche furono le azioni politiche e diplomatiche da lui condotte a termine con successo. Una persona in preda all’amarezza e vittima di forti tormenti nonostante che il successo gli abbia arriso per buona parte dell’ esistenza? Sicuramente, tanto da conoscere un grave appannamento della propria immagine sia a motivo del probabile coinvolgimento in una congiura capeggiata dal cognato Licinio Murena, sia perché la scarsa irreprensibilità della giovane moglie gli causò spesso pubblico disonore. Non a caso, non fu profeta in patria, poco amato nella sua Arretium, in particolare nella classe patrizia. E non bisogna dimenticare le numerose sofferenze psicofisiche procurategli da un temperamento molto complesso e da una salute assai cagionevole (tra i vari malanni, soffrì anche di un’insonnia ribelle che lo perseguitò a lungo).
Amico e consigliere dell’uomo più potente del suo tempo, non accettò mai cariche onorifiche e preferì dedicare le proprie energie a sostenere un circolo letterario che si era formato intorno a lui. Chi fu dunque l’aretino Gaio Cilnio Mecenate? Per rispondere a questo interrogativo è importante innanzitutto chiarire, per quanto possibile, quale sia stata la sua appartenenza culturale. Egli aderì all’epicureismo, la dottrina filosofica il cui iniziatore fu il pensatore greco Epicuro (341 – 270 a. C.) e che ebbe un’ampia diffusione anche nel mondo romano. Alla base di tale filosofia sta una sorta di edonismo moderato, secondo cui la sorgente della felicità va ricercata nel piacere, non un piacere sregolato di cui si diventa schiavi, ma, piuttosto, un piacere che è assenza di dolore, apprezzamento delle cose semplici, distacco da ogni avidità. Mecenate sembra aver optato, invece, per una concezione edonistica più radicale, assolutizzando le passioni e rendendosi incapace di sopportare, come aveva raccomandato Epicuro in nome di una sovrana serenità interiore, le sofferenze fisiche e persino la morte.
L’impossibilità di godersi pienamente la vita come avrebbe desiderato causò al Nostro una sorta di costante, invincibile ansietà. Egli non rinunciò alla “luxuria”, ma non ne trasse la consolazione che ricercava affannosamente. Ha scritto Jean-Marie André: “La curiosità, l’originalità, l’eccentricità, costituiscono in Mecenate il rovescio di un’insoddisfazione pessimista che lo invade gradualmente … L’epicureismo non ha liberato Mecenate dal suo temperamento … L’epicureismo ha permesso a Mecenate di circoscrivere le sue passioni, non di risanarle”. C’è poi, come si è detto, il Mecenate politico. Grande sostenitore della monarchia, la volle umana e moderata. Non fu certo un democratico, ma comprese l’importanza del consenso popolare e capì che per ottenerlo erano importanti la propaganda e la manipolazione dei sudditi. Decise di rimanere estraneo alla lotta politica per non compromettersi con la massa, fiero com’era delle sue origini e del suo “status”. Preferì agire dietro le quinte del potere, accentuando il ruolo dei confidenti e dei favoriti. Ciò gli permise di conservare una certa libertà, quella dello spirito, l’unica alla quale tenesse per davvero.
E che dire di Mecenate padre del mecenatismo? A questo riguardo è opportuno ricordare che egli non fu spinto a proteggere gli artisti perché credeva nella libertà dell’arte, ma piuttosto dall’amicizia e dalla cortesia che sfioravano il “clientelismo”. Inoltre si rese conto che l’arte poteva costituire un valido “instrumentum regni”. Gli piacque stimolare gli ingegni, forse dispiacendosi di non essere stato lui uno di quelli e tuttavia godendo delle loro creazioni artistiche, senza entusiasmi particolari ma con ottimo spirito pratico. Personalità complessa e contraddittoria, dotata di alte qualità intellettuali ma incapace di elevarsi quanto avrebbe voluto,
Mecenate si presenta come una figura affascinante, riguardo alla quale Jean-Marie André ha sostenuto quanto segue: “L’elemento più originale della sensibilità di Mecenate è pur sempre la dimensione metafisica. Mecenate vede l’invisibile, ha il presentimento di mondi occulti. I suoi frammenti esprimono allo stesso tempo la vita segreta delle cose reali e la presenza insidiosa delle forze e delle ombre. Per atavismo come per temperamento, Mecenate non riesce a separare l’esperienza sensibile dal sentimento dell’esistenza e della mortalità. Le ossessioni scaturite dall’inferno etrusco non sono nulla in confronto ad alcune altre scoperte: il senso della fine, l’inquietudine”

