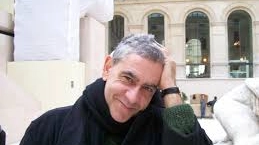
Il professor Giuseppe Patota
Arezzo, 22 maggio 2016 - SI FA PRESTO a dire «bravo». Ma sappiamo davvero tutto sul significato di questa parola? Si è posto la stessa domanda il professor Giuseppe Patota durante una lezione sulla lingua dei Promessi Sposi, all’ateneo aretino del Pionta. Anzi, a dirla tutta, la domanda l’ha posta uno studente al professore: «In italiano la parola bravo ha un significato positivo: è bravo chi è ‘abile’, ‘capace’; oppure chi è ‘buono’, ‘onesto’ e fa il suo dovere. Come mai, invece, i Bravi di Alessandro Manzoni tutto erano meno che bravi?».
In effetti, ha pensato Patota, lo studente aveva ragione. Anche bravata non ha un significato positivo, e nemmeno l’espressione notte brava: una bravata, infatti, è un comportamento o un discorso provocatorio, tracotante o minaccioso; una notte brava è una notte turbolenta, fatta di bravate, atti di teppismo o divertimenti sfrenati. E così, il professore ha pensato che la domanda dello studente meritasse una risposta articolata. Molto articolata. Un libro. Ed è così che è nato «Bravo!», edito da Il Mulino (11 euro).
D’altronde, spiega Patota riecheggiando Pericle, «Al Pionta facciamo così». Ne è nato un lavoro che è andato fino al fondo etimologico della parola «bravo», che lo studioso spiega così: «Il termine ha il suo antecedente nel latino barbarus (a sua volta proveniente dal greco bàrbaros), che naturalmente ha dato origine, come è facile intuire, anche a barbaro e che indicava lo‘straniero’, in quanto tale non solo rozzo e incivile, ma anche crudele e feroce. Bravo e barbaro, dunque, sono parole sorelle: perciò non meraviglia che la prima, bravo, nella sua storia remota abbia condiviso molte valenze negative della seconda, barbaro. Nell’italiano antico, dall’inizio del Trecento fino alla fine del Quattrocento, l’aggettivo bravo significa più cose insieme: ’feroce’, ‘crudele’, coraggioso sì, ma fino alla temerarietà. È molto difficile distinguere i significati positivi da quelli negativi.
QUESTA DIFFICOLTÀ si fa ancora più vistosa dalla fine del Quattrocento in poi. Nell’Italia tormentata dai conflitti che fra il 1494 e il 1559 la riducono a un campo di battaglia e a un oggetto di conquista da parte degli eserciti stranieri, non si può guardare troppo per il sottile, e le componenti negative passano in secondo piano: in battaglia, in guerra, quando c’è da menar le mani, essere bravi è una virtù necessaria, nel senso machiavelliano del termine. È in questo periodo che nascono i Bravi (bravi non più aggettivi, ma nomi): sbandati delle compagnie di ventura travolte dagli eserciti stranieri che diventano sgherri al servizio dei potenti. Sono questi i Bravi di cui ci parla Manzoni nei Promessi Sposi.
Naturalmente, c’è bravo e bravo: c’è il bravo vero e il bravo solo a parole. Il secondo, il bravo a parole, diventa un personaggio da commedia: lo troviamo nella commedia rinascimentale italiana, nei canovacci della commedia dell’arte, perfino nelle commedie di Carlo Goldoni: funziona, perché si fonde e si confonde col personaggio del soldato spaccone; il primo, il bravo vero, diventa un personaggio da commedia; il secondo, invece, diventa un personaggio da tragedia, anzi: da melodramma tragico. Come lo Sparafucile che, nella Mantova del secondo Cinquecento in cui è ambientato il Rigoletto di Verdi, pugnala Gilda.
Negli stessi anni in cui comincia a essere adoperata anche come nome per indicare gli individui di basso livello, la parola bravo viene anche depenalizzata: assume prima il nuovo significato di ‘capace’, ‘abile’ e poi il significato di buono che ha mantenuto fino a oggi». Ma non è finita. Tra il Seicento e il Settecento bravo diventa addirittura un complimento: «Impossibile non pensare ai bravo e ai bravissimo che ricorrono in Largo al factotum, del Barbiere di Siviglia. Ai bravo e ai bravissimo che Figaro rivolge a sé stesso in forma di citazione fecero eco, nei teatri di tutto il mondo, i bravo! e i bravissimo! gridati dal pubblico all’artista, agli artisti e alle artiste di turno.
L’ITALIANISMO bravo! si è diffuso in più di quaranta lingue del mondo come esclamazione invariabile nel genere e nel numero; è diventato un marchio di automobili, di ciclomotori e perfino di biancheria intima femminile: in rete, il reggiseno “bravissimo” fa concorrenza al “wonderbra”; tutte e due sono parole macedonia, il cui primo e l’ultimo pezzetto è bra, che in inglese vuol dire reggiseno. Nella storia della musica italiana, il bravo! più famoso dopo quello che echeggia nel Barbiere di Rossini è il brava cantato da Mina nella canzone divertissement costruita nel 1965 da Bruno Canfora per saggiare le straordinarie capacità vocali di questa cantante che, con prodigiose scorribande lungo un’estensione vocale di oltre due ottave, ne restituì un’esecuzione strabiliante».
Dory D'Anzeo

