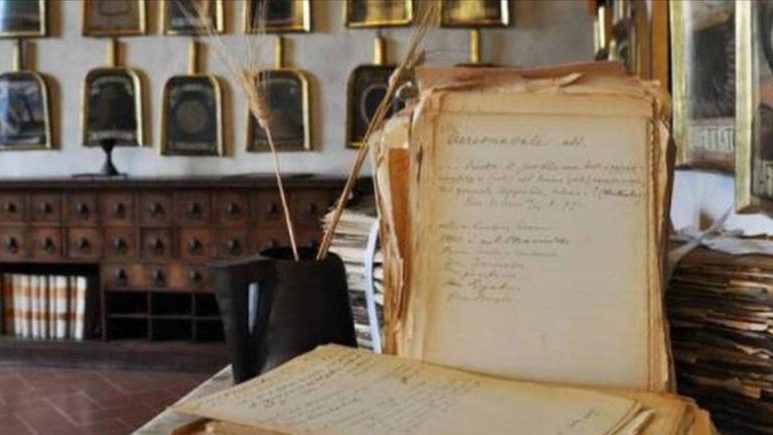
La Crusca
Firenze, 24 agosto 2022 - La Sieve, la Pesa, la Lima, la Cecina o la Magra. Fiumi o affluenti maschili declinati al femminile, perché mai? Non è facile trovare una regola generale che governi l’attribuzione di genere, uno schema perfetto, imprescindibile, che non ammetta eccezioni. Esiste piuttosto una tendenza e bisogna considerare caso per caso. “Un fiume – spiega Massimo Fanfani dell’Accademia della Crusca, storico della lingua italiana che dal 2004 condirige la rivista ‘Lingua nostra’ - non si fonda su un genere “reale”, come avviene per gli esseri sessuati, ai quali è quasi sempre pacifico attribuire un maschile o un femminile. E nemmeno su elementi che possano esser ricondotti concettualmente all’uno o all’altro sesso. Come l’etimologia dei nomi dei fiumi, che per lo più risalgono alla notte dei tempi, non di rado è incerta, così il loro genere grammaticale, potendo dipendere da vari fattori remoti, non è facile da giustificare”.
Eppure qualcosa che differenzia i nomi al maschile da quelli al femminile c’è: “In origine – spiega l’Accademico che ha realizzato sul tema un dettagliatissimo studio di raro pregio - sulla base di credenze, miti, fantasie popolari, è probabile che ci si orientasse verso un nome femminile quando si vedeva nell’acqua del fiume una fonte di vita e un simbolo di fecondità. E al contrario, verso un nome maschile quando si avvertiva come preponderante la potenza e l’impeto del flusso della corrente, flusso che determina da solo il proprio corso dando un’idea di forza e di maestosità. La cosa è evidente per quei fiumi che furono ritenuti sacri e perciò li si volle ricollegare a divinità fluviali maschili o femminili o a qualche personaggio mitico che avrebbe dato loro il suo nome. E per le divinità fluviali si nota spesso, nelle diverse civiltà antiche, ora il prevalere dell’una ora dell’altra tendenza”. Quando invece all’origine c’erano elementi concreti, come le caratteristiche del fiume stesso o delle sue acque, il tipo di territorio attraversato, la flora circostante, ecc., il genere di tale elemento determinava ovviamente quello del fiume: “Ad esempio Acquacheta – spiega l’accademico -. La Lima, affluente del Serchio, se si chiamò così per metafora dall’arnese del fabbro, non poteva che esser femminile. Senza possibilità di equivoci sarà anche il genere di quei nomi dovuti all’unione di un termine generico di corso d’acqua (maschile o femminile) con un aggettivo o un determinante: Flumendosa, Rimaggio, Rionero sono per forza maschili”.
Scriveva Pier Gabriele Goidànich nella sua Grammarica italiana del 1918: “Sono maschili, come fiume, i nomi delle acque correnti che non terminino in –a: ad esempio il Po, il Piave, il Crati. Quelli in –a sono ordinariamente femminili: la Secchia, la Lima, la Senna, con poche eccezioni come l’Adda, il Volga, il Niagara. “Ciononostante la norma inculcata dalla scuola ha funzionato – scrive Fanfani in un suo dettagliato articolo sul sito dell’Accademia della Crusca intitolato ‘Fiumi femminili, fiumi maschili’ - tanto che è stata largamente adottata nell’italiano degli scriventi colti, mentre gli usi originari o sono andati scomparendo o si sono conservati nella parlata locale e popolare”. Ci sono stati casi anche di cambio di genere, che quando “è riuscito ad imporsi anche localmente, è proprio perché lo si è ritenuto “più corretto”. Casi in cui, scrive Fanfani: “Le spinte al cambiamento di genere provengono quasi sempre da ambienti esterni o più elevati rispetto a quello locale; ambienti nei quali, evidentemente, conta di più regolarizzare e uniformare la lingua che accertare e rispettare l’uso popolare”.
“Naturalmente ci sono anche casi in cui l’adeguamento al maschile non è avvenuto o che è rimasto in bilico – spiega il professor Fanfani -. Il Sieve, che aveva cominciato ad affacciarsi così maschilizzato nella seconda metà del secolo XIX in opere di geografi e naturalisti, non ce l’ha fatta. D’altra parte il fiume Magra oggi risulta trattato generalmente come maschile, anche se molti in Toscana continuano a sentirlo femminile”.
“Come già in latino – spiega Massimo Fanfani - fra i nomi dei fiumi italiani prevalgono i maschili, soprattutto quando si considerino i grandi fiumi e specialmente quelli che sfociano in mare: Tagliamento, Adige, Po, Reno, Tevere, Arno, ecc.. Ma fra i fiumi sfocianti in mare che un tempo erano femminili e che in certi casi lo sono ancora, vanno pure ricordati almeno Piave, Brenta, Marecchia, Pescara, Cecina, Magra. Oltre a questi sono femminili diversi fiumi minori, in particolare fra gli affluenti. Fra quelli dell’Arno: Sieve, Greve, Pesa, Elsa, Egola, Era, ecc. Come si vede, tutti i fiumi che terminano in –o e in –i (questi piuttosto rari) sono maschili; quasi tutti quelli che terminano in –a e una parte di quelli che terminano in –e sono invece femminili”. Maurizio Costanzo

