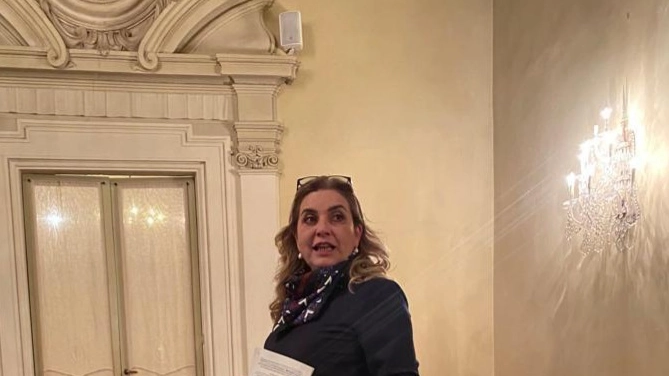
Letizia Pagliai nel corso della conferenza al Rotary Lorenzo il Magnifico
Firenze, 14 aprile 2022- È stata una serata davvero particolare quella organizzata a Villa Viviani dal Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, dedicata al tema “Antenati. L’ereditarietà di status socioeconomico delle famiglie fiorentine nel lungo periodo”. Relatrice la Professoressa Letizia Pagliai, del Dipartimento di Management dell'Università di Torino.
“Poco cambia in 700 anni nella composizione delle famiglie fiorentine fra chi è ricco e chi non lo è - ha esordito la professoressa-. Lo straordinario dato su Firenze ci è stato fornito da uno studio di Bankitalia del 2016 ed implica che c'è molta meno mobilità economica nel lungo periodo di quanto le cifre a breve termine farebbero credere”. Nella sua relazione ai soci e agli ospiti del Rotary Club Lorenzo il Magnifico, presieduto da Carlo Steinhauslin, la Professoressa Pagliai ha spiegato il perché dati come questo siano oggetto di studio “Molti ritengono auspicabile un’elevata mobilità, come segno di una società che tende all’uguaglianza delle opportunità. La mobilità intergenerazionale non ha conseguenze solo in termini di equità ma anche di efficienza: se le posizioni sociali sono in qualche modo predefinite, si affievoliscono gli incentivi all’investimento in capitale umano e si osservano sprechi nell’allocazione delle risorse, ovvero nelle posizioni occupate da individui dotati ma privi di occasioni di ascesa sociale. Un quesito rilevante è se l’influenza delle condizioni familiari di origine si limiti a una generazione. Il lavoro di Bankitalia stima invece l'elasticità intergenerazionale su di un orizzonte temporale molto lungo (quasi 700 anni, circa 20 generazioni)”.
L'analisi cui ha fatto riferimento la professoressa sfrutta i dati censuari del 1427 su reddito da lavoro e ricchezza reale per la città di Firenze e quelli delle dichiarazioni dei redditi dei fiorentini nel 2011. “Il reddito e la ricchezza reale al 2011 di ciascun soggetto viene messo in relazione con il reddito e la ricchezza reale di coloro che nel 1427 condividevano il suo stesso cognome (pseudo-antenati). Il Catasto Fiorentino è uno dei più importanti e basilari documenti per la storia sociale di Firenze nel Rinascimento, in quanto fornisce significative informazioni sulla maggior parte degli abitanti della città. Sono state comparate, dunque, le dichiarazioni fiscali dei contribuenti del 1427 con le dichiarazioni dei redditi dei fiorentini del 2011”.
Com‘è possibile che tracce di ereditarietà socioeconomica persistano nel lunghissimo periodo? “Una possibile spiegazione potrebbe risiedere in un particolare aspetto della struttura della società. Ovvero, una società strutturata per blocchi sociali, nella quale gli individui si muovono tra generazioni solo all’interno del gruppo di appartenenza, con redditi che possono essere maggiori o minori di quelli dei padri, ma che restano comunque nell’intervallo del proprio blocco di appartenenza. Il punto importante, rispetto alle altre città italiane, è che le “famiglie” di lunga tradizione patrimoniale sono ben rappresentate in istituzioni finanziarie, bancarie, private laiche e secolari come la Misericordia oppure i Buonomini di S. Marino. La peculiarità del sistema fiorentino è data da una serie di fattori storici in una dialettica continua fra terra (campagna) e affari (città: commerci e finanza)”.
La professoressa Pagliai ha poi sottolineato anche come il patto sociale che struttura la società permettendole di non subire “violenti” rovesciamenti dello status quo, risieda nella peculiarità del contratto mezzadrile e nel fidecommesso, ossia un istituto originato dal Diritto romano che in Toscana sopravvisse alla sua ufficiale abolizione del 1865. “Si trattava di un espediente per aggirare le norme che escludevano completamente o in parte dalla successione certe categorie di persone, ad esempio le donne. Si ritiene che il fedecommesso sia uno dei precursori del Trust, istituto giuridico caratteristico dei paesi di Common Law, e l’analisi delle odierne scelte finanziarie delle “famiglie” fiorentine tendono a confermare queste scelte, ispirate ad una consuetudine di 700 anni fa”.
Caterina Ceccuti

